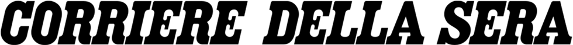La guerra nelle case e nelle famiglie
di - Martedì 27 Ottobre 2020 ore 09:33

“Raccoglieva le briciole con le dita bagnate”, questo il titolo del pezzo del mio blog dove ho raccontato di Nazzareno Lattici, soldato e prigioniero nella seconda guerra mondiale, secondogenito di nove fratelli diventato il maggiore dopo la morte del primo fratellino.
Ma Nazzareno non è stato il solo, della famiglia Lattici, a partire militare e ad essere preso prigioniero durante la guerra, perché anche babbo Giuseppe aveva subito la stessa sorte durante il conflitto del 15/18.
Ma la guerra non è stata combattuta solo al fronte, ma anche nelle singole famiglie e nelle singole case.
E’ per questo che ho deciso di farmi raccontare qualcosa di questa famiglia, una famiglia come tante, una famiglia di contadini molto numerosa, alle prese nelle diverse generazioni, con figli al fronte, con la miseria e le difficoltà di due conflitti mondiali.
Questi ricordi sono testimonianze di due dei fratelli Lattici, Marino e Cesare.
Babbo Giuseppe era un trovatello, e secondo quanto riportano i registri del brefotrofio consorziale della congregazione di carità di Osimo, fu abbandonato “alla ruota”, il 21 aprile 1894; accanto si legge l’annotazione: “il bambino ha l’età apparente di un giorno”.
Fu battezzato lo stesso 21 aprile 1894, nella parrocchia del Duomo, da Don Vincenzo Bangelletti, con madrina Vincenza di Apollinare Campanelli, e gli furono attribuiti i nomi di Giuseppe, Luigi, Mario e il cognome Lattici.
Fu consegnato provvisoriamente a baliatico a certa Violante, moglie di Campanelli Apollinare - custode della ruota della Parrocchia di San Gregorio di Osimo - ed il giorno successivo, il 22 aprile 1894, fu affidato a Ragoni Rosa e a suo marito Zitti Antonio di Filottrano, che lo hanno cresciuto amorevolmente come un suo stesso figlio. (*1)
Il cognome di Giuseppe rimase “Lattici”.
Marino ricorda bene quella che per lui e per i suoi fratelli era la loro zia, Caterina, sorellastra del babbo.
Caterina era amorevolissima con tutti, ma specialmente con Giuseppe, che rinunciò persino a sposare il suo innamoratino, certo Zenobi di Storaco per non allontanarsi dalla famiglia.
Cesare ricorda quel giorno che Zenobi venne ufficialmente a chiederla in moglie.
“L’aveva corteggiata tanto, era innamoratissimo – dice Cesare – e quel giorno si decise a farle la sua dichiarazione d’amore. Ma Caterina rispose che non poteva maritasi, che non poteva lasciare la famiglia perché c’era bisogno di lei, e aggiunse: non devi essere geloso perché io non mi sposerò mai con nessuno. E fu proprio così”.
Zia Caterina, durante l’inverno, nel periodo di riposo dal lavoro nei campi, non si muoveva mai dal suo telaio piazzato nella stanza più fredda della casa, scaldandosi i piedi con uno scaldino pieno di carboni ardenti.
E lavorando di gran lena, riuscì a confezionare il corredo a tutte e tre le figlie di Giuseppe, Dina, Elvira e Rosetta.
Caterina era piccola, odiava la sua statura a tal punto che nel farsi fotografare, salì sopra uno sgabello per diventare un po’ più alta. (vedi foto)
Il giovane Giuseppe viene descritto da Marino come un uomo dinamico, gioviale e canterino che nelle domeniche delle Palme andava a cantare la Passione di Cristo con un trio accompagnato da un organetto, da un triangolo e da un tamburello.
Ma con la prima guerra mondiale, la vita serena di Giuseppe subì uno scossone.
Fu richiamato alle armi il 12 settembre 1914, assegnato inizialmente al 63° Reggimento fanteria, con il grado di “caporale” poi al 32’ Reggimento (231 fanteria) dell’Esercito Militare Italiano, e successivamente al 221° reggimento fanteria partecipando alle campagne di guerra 1915, 1916, 1918.
Eppure Giuseppe aveva la dispensa in tasca, a causa di una menomazione al suo braccio destro.
Quella menomazione al braccio, Giuseppe, se l’era procurata un giorno qualunque, mentre percorreva la strada lungo la selva Corradori che collega con Via Vallevecchia.
Giuseppe accompagnava un carro stracarico di ghiaia e pietre, trainato da un paio di vacche, giù per una discesa a forte pendenza, e nel punto dove la strada era più inclinata, la fune che reggeva la martinicca si spezzò.
Giuseppe tentò di arrestare la corsa del carro mettendo una grossa pietra davanti alla ruota, ma la ruota non fermò la sua corsa, scavalcò la pietra e trapassò il polso della mano destra di Giuseppe procurandogli una disabilità permanente.
Ma poteva andargli davvero peggio. Così, la famiglia di Giuseppe, molto religiosa, decise di far costruire un piccolo tabernacolo di legno al margine della strada in cui era avvenuto l’incidente.
Un’immagine del Sacro Cuore di Gesù, con un doppio scopo: quello di ringraziare il Signore per la protezione data a Giuseppe e quello di dare ai passanti l’opportunità di farsi il segno della croce o recitare una preghiera durante il loro cammino.
Quel tabernacolo era particolarmente caro alla famiglia adottiva e anche alla famiglia Lattici, tant’è che mamma Palmina non mancava di portarci dei fiori freschi ogni giorno e quando non poteva, lo comandava ai figli.
Quella menomazione avrebbe dovuto esentare Giuseppe dal servizio militare, ma mentre nel primo rigo del suo foglio matricolare si legge chiaramente: “Soldato di leva/classe 1918, distretto di Ancona e lasciato in congedo illimitato - 19 marzo 1914, subito sotto c’è scritto: “Chiamato alle armi e giunto il 12 settembre 1914 – 63’ Reggimento fanteria”.
La menomazione fu riconosciuta a Giuseppe solo il 15 ottobre 1940, dopo una visita collegiale all’ospedale di Ancona.
Nel foglio matricolare c’è scritto testualmente: “Sottoposto a visita medica collegiale presso l’ospedale militare di Ancona e con determinazione della Direzione dell’ospedale stesso riconosciuto non idoneo permanentemente al servizio militare e riformato per esito di frattura delle ossa dell’avambraccio destro con grosse lesioni e conseguente perdita delle funzioni della mano destra. Posto in congedo assoluto in seguito alla suddetta consegna”
Forse Giuseppe era stato richiamato alle armi nella seconda guerra mondiale?
Giuseppe, durante il primo conflitto mondiale, aveva fatto tre lunghi anni di militare e di prigionia, mutando di carattere, perdendo la sua allegria e la giocosità che lo aveva contraddistinto durante gli anni della gioventù.
Giuseppe non raccontò mai della sua prigionia, tant’è che i suoi figli non sanno niente e non conoscono neanche il luogo dove il padre fosse stato portato. Anzi, hanno saputo della prigionia del padre dalle ricerche fatte per la scrittura di questa memoria.
Nel foglio matricolare si legge che fu preso prigioniero di guerra il 16 giugno 1918, e “rimpatriato” il 9 novembre 1918, e niente altro.
Giuseppe fu fatto prigioniero il 16 giugno 1918, e il 221° reggimento fanteria combatteva con la brigata Ionio nella battaglia del Solstizio o seconda battaglia del Piave.
Il 221° reggimento fanteria passò il Piave il 31 luglio 1918, poco dopo che Giuseppe fu preso prigioniero, e prima della firma dell’armistizio le cui trattative iniziarono a Villa Giusti il 1 novembre dello stesso anno. La crudeltà della battaglia e il valoroso impegno del 221° reggimento e del 222° valsero loro il riconoscimento della medaglia di bronzo al valor militare (anno 1920). (*4)
Giuseppe tacque, tacque sempre, e di notizie certe sui prigionieri ne circolarono poche e frammentate, e di loro sapevano poco o nulla anche le stesse famiglie.
Nei testi storici si legge che i prigionieri del Piave morirono in tantissimi e non solo per le ferite ma anche per malattia e per la fame, sia durante la prigionia, sia dopo il loro rimpatrio in territorio italiano dove furono internati e interrogati.
E questo perché si temeva che la loro prigionia fosse un atto di vigliaccheria, che avessero cioè preferito farsi prendere prigionieri piuttosto che adempiere al proprio dovere di soldato nell’inferno del fronte.
Giuseppe sposò Palmina Accorroni un anno dopo il suo rimpatrio, l’8 ottobre 1919, e da questa unione nacquero nove figli: il primogenito Nazzareno che muore prima di compiere tre anni, il secondogenito Nazzareno classe 1922, Dina 1924, Elvira 1927, Mario 1929, Marino 1931, Antonio 1933, Rosetta 1936 e Cesare 1939.
Era il capofamiglia, Giuseppe, di una famiglia numerosa.
Tutti quanti i figli ed anche mamma Palmina, oltre a zia Caterina, aiutavano babbo Giuseppe a coltivare i sei ettari di terra con grano, granturco, foraggio e vigneto, che servivano a sfamare la famiglia, le vacche da lavoro, i vitelli da ingrasso e gli animali da cortile.
Senza grandi pretese, la vita di quella famiglia di contadini scorreva tranquilla in quel di Filottrano, andando avanti in modo semplice e onesto con la forza delle braccia.
Giuseppe, dopo il militare e la prigionia, era diventato un altro uomo, aveva perso la sua allegria, era diventato saggio ed equilibrato e quando sopraggiunse il secondo conflitto mondiale, la sua lucidità e il suo buon senso gli permisero di programmare ogni cosa, per proteggere la famiglia ed evitarle il più possibile la sofferenza della fame.
Come mettere su una riserva preziosa di grano nascondendolo in damigiane sotto il pavimento del forno, ad esempio, mettere via il più possibile nascondendole alla perfezione riserve di cibo per la famiglia e per gli animali, o costruire un rifugio dove andare a ripararsi durante i bombardamenti.
C’era una vallata – dice Marino – di fronte alla nostra casa a Filottrano, con un argine alto cinque o sei metri, ideale per costruire un rifugio sotterraneo. Babbo Giuseppe era espertissimo di cose di guerra, e in men che non si dica organizzò un cantiere di tipo familiare consegnando a tutti gli adulti della famiglia vanghe e zappe, picconi e carriole, e sotto la sua direzione fece prendere forma ad un rifugio di tutto rispetto. C’era fretta, il fronte era già nella vicina Macerata. Tutt’intorno c’erano postazioni di nemici ed alleati, la posta in gioco era altissima per tutti e due gli eserciti, il porto strategico di Ancona. Accerchiati da alleati e nemici – continua Marino - non facevamo certo vita facile. Un giorno babbo Giuseppe fu preso a fucilate da un tedesco. Noi non uscivamo mai dal rifugio, ma c’era bisogno che qualcuno andasse a controllare la casa e soprattutto a governare gli animali. Così babbo Giuseppe uscì dal rifugio per raggiungere casa, ma il tedesco lo avvistò e cominciò a sparargli addosso. Babbo era veloce come un fulmine, e tra una piccola corsa ed un’altra, riparandosi dietro ai cavalletti di grano nel campo vicino, ce la fece a ritornare salvo nel rifugio”.
Intanto il fronte si avvicinava sempre di più.
“La nostra casa colonica – dice Marino – era posizionata nella parte più alta e pianeggiante del podere, proprio di fronte all’argine col rifugio. Intorno all'aia c’era uno spazio di 50 mq circa, uno spazio utile per piazzare la trebbia del grano, il pagliaio, il fieno, il gozzo che raccoglieva l'acqua piovana per gli animali domestici.
Su questo spazio e nei campi limitrofi, col passaggio del fronte, nella notte tra il 1 e il 2 luglio 1944, si scatenò una tragica battaglia tra un carro armato tedesco e diversi carri armati polacchi arrivati da San Biagio.

Noi eravamo nel rifugio sotto la collina teatro dello scontro, e non potevamo vedere niente – dice ancora Marino - ma sentivamo fortissimo il rumore delle cannonate in successione e a distanza ravvicinata, come in una commedia ascoltata per radio. Ad ogni colpo le vibrazioni ci scuotevano, ci facevano cadere addosso pezzi di terreno dal soffitto del rifugio, eravamo in mezzo ad un vero e proprio terremoto.
Uno di quei colpi, sparato da un carro armato polacco, sfondò il muro della nostra stalla uccidendo il toro pronto per la macellazione. Avevamo perso un animale prezioso. Tutto a un tratto sopraggiunse un silenzio profondo. Uscimmo dal rifugio in punta di piedi, uno dietro l’altro, salimmo su fino alla cresta della collina e scorgemmo un carro armato tedesco bucato da più parti, e accanto, un militare tedesco morto. (*2)
Si capì che era ora di lasciare il rifugio e cercare di salvare la pelle - continua Marino - perchè anche il rifugio ormai, non sembrava più essere sicuro”.
Le notizie ascoltate con la “galena” costruita da Nazzareno, che era al fronte, fecero decidere definitivamente la famiglia Lattici di lasciare Via Vallevecchia. Non sapevano dove andare, se non lasciarsi trascinare dall’istinto di fuggire da quel posto. In fila indiana, uno dietro l’altro, babbo Giuseppe, mamma Palmina, zia Caterina e i fratelli, salirono su per la stradina, e attraverso i campi si misero in cammino, senza mèta, in attesa che il fronte si allontanasse per poter ritornare a casa.
Marino ricorda che, appena arrivati in cima, davanti ad una piccola trincea costruita dai tedeschi ormai abbandonata, c’era un soldato morto, a testa in giù, e che a lato del percorso c’era un campo di granoturco.
I loro vicini avevano raccontato che quel campo color oro era sporco di una lunga scia di sangue, forse di un soldato ferito che ce l’aveva fatta a scappare.
“Andare, andare via, ma dove? Io ero il più piccolo – racconta Cesare – e non potendo stare al passo con gli altri, venivo portato sempre in braccio e a volte, per mano. Babbo cercava di tranquillizzarci tutti – dice Cesare – e non faceva altro che ripetere va tutto bene va tutto bene, e ci pregava di stare ben distanti l’uno dall’altro …… ho capito da grande, che mantenere la distanza era una precisa strategia: nel caso che qualcuno di noi venisse colpito, la distanza avrebbe salvato gli altri”.
Il gruppo si diresse verso Montefano.
“Ad un certo punto – continua Cesare – era necessario attraversare il fiume. Babbo Giuseppe si mise alla ricerca di un piccolo ponticello, e da lì attraversammo verso l’altra sponda. Camminammo per un paio di chilometri e giungemmo ad una casa colonica. Li abitavano i “Coppari”. Fuori dalla casa dei Coppari , per scoraggiare i malintenzionati, un grosso cane legato ad una catena tirava il collare in su e in giù per una quindicina di metri. Babbo Giuseppe che guidava la fila, non ce la fece a scansarlo e fu prima azzannato ad un calcagno e poi preso con i denti ad una gamba di pantalone. Il cane non voleva lasciare la presa. Fu Alfredo che si era unito a noi perché voleva fidanzarsi con mia sorella Elvira, che tirò via di forza babbo Giuseppe da quella morsa terribile, permettendo al gruppo di riprendere il cammino”.
Il viaggio della famiglia Lattici terminò a Montefano, dove furono ospitati da alcuni conoscenti, e dove rimasero per circa una settimana.
Appena il fronte si allontanò, ritornarono nella loro casa.
“ Il fronte, al suo passaggio, aveva lasciato nei nostri campi residui bellici , mine, bombe a mano, polvere da sparo formato spaghetti… - dice Marino – ed io ed i miei fratelli non conoscendo il pericolo, giocavamo a costruirci armi, dei piccoli carri armati, e persino un fucile rudimentale. Con i bossoli per i cannoni, rimaneggiati e privati del tappo, ci costruivamo dei contenitori che potevano servire per piantarci qualcosa o addirittura da thermos per l’acqua calda”.
Nella mente dei ragazzi , anche la guerra, è un gioco.
“Un giorno – racconta ancora Marino - sentimmo dire che due fratellini erano morti allo scoppio di una mina tedesca che era rimasta inesplosa. Ci avevano giocato allo stesso modo con cui ci giocavamo noi. Mio fratello Mario, poi, appena quindicenne, si era salvato con una mossa fortuita come quella che avrebbe potuto fare un artificiere provetto. Avvistata una mina tedesca inesplosa, la colpì più volte con un sasso, senza rendersi conto del pericolo, e poi la pose sopra una fascina di legna e l’appiccò. Fu abbastanza scaltro però, perché pose la fascina dietro una quercia con un diametro di alcuni metri che attutì il colpo. La mina scoppiò ma Mario riuscì ad andare via di corsa più veloce di un treno mettendosi in salvo dall’esplosione che dopo pochi secondi si diffuse a oltre 5-6 Km in linea d’aria. Noi da casa – conclude Marino – udimmo chiarissimo quello scoppio, senza sapere che era il nostro fratello Mario che aveva corso quel gran pericolo”.
“La guerra continuava in cento modi – raccontano i fratelli - ma il fronte era passato e non c’era più quella paura di vedere sbucare il nemico da ogni angolo, affamato e prepotente. E poi babbo Giuseppe era attentissimo, e anche buono d’animo e non provocava mai la rissa e nemmeno rifiutava a nessuno quel che poteva dargli”.
La sera che fu costruito il rifugio, ad esempio, Giuseppe, dette ospitalità ad un soldato tedesco di passaggio che stanco e stremato chiese riparo per la notte. Il tedesco era armato ma Giuseppe lo accolse come un fratello e il soldato “nemico” si commosse quando prima dell’alba, ringraziando, sparì nel nulla riprendendosi le sue armi.
E un altro giorno un partigiano affamato gli chiese il vitello pronto per essere venduto .
Giuseppe stava governando le bestie nella stalla, quando vide apparire all’improvviso tre partigiani. Uno di questi era particolarmente agitato e chiedeva con insistenza la consegna del vitello. “Abbiamo fame” – disse il ragazzo partigiano per giustificarsi – Giuseppe lo guardò negli occhi e lo lasciò fare, e il partigiano si portò via il vitello. (*3)
Il toro ucciso, il vitello rubato, ma Giuseppe, potè comunque dare da mangiare ai propri figli perché da uomo previdente che era diventato, aveva il grano sotterrato, le mele nascoste e gli erano comunque rimaste delle uova, dei polli e delle galline.
Ma non solo la famiglia Lattici ebbe a che fare, in quel periodo, con la fame e con la prepotenza dei soldati.
Un giorno, una quarantina di soldati tedeschi si presentarono alla massaia della famiglia Verolo, a circa un chilometro dalla casa dei Lattici, chiedendo che fosse preparata per loro una grossa frittata.
La massaia rispose che non aveva abbastanza uova per tutti quegli uomini. “keine probleme” gli risposero, e in poco tempo, razziando i pollai della zona, fornirono la donna di una cinquantina di uova. La massaia sbattè le uova uno dopo l’altro e padella su padella, cucinò le frittate per tutti i soldati.
Dopo il passaggio del fronte, gli alleati avevano conquistato le colline dove abitavano i Lattici, punto assolutamente strategico per il controllo del porto di Ancona.
Agli americani da mangiare non mancava e anzi, erano loro che distribuivano del cibo alle popolazioni in cambio di qualche umile lavoretto. Anche Marino si ricorda di aver lavorato qualche volta per loro in cambio di una cioccolata o di una scatoletta.
Poi la guerra finì e la vita dei campi riprese regolarmente.
Nel 1953 la famiglia Lattici si trasferì a Sant’Ermo, allora frazione di Casciana Terme.
I sei ettari di terra non bastavano a sfamare quella famiglia numerosa e attraverso la conoscenza con la famiglia Parasecoli di Usigliano, decisero di trasferirsi in Toscana. Tutti, eccetto Elvira che rimase a Filottrano per sposare Alfredo, e Nazzareno che si sposò con Dina.
Giuseppe morì il 19 novembre 1961 e fu seppellito nel cimitero di Sant’Ermo insieme a mamma Palmina, zia Caterina e al figlio Mario.
Marino, Cesare e Dina risiedono a Usigliano, Rosetta a Sant’Ermo, Antonio a Livorno, Nazzareno ed Elvira sono morti e sono seppelliti a Filottrano.
La casa colonica dei Lattici è stata acquistata da un signorotto inglese e trasformata in una bellissima villa. I vicini dei Lattici hanno quasi tutti lasciato il podere e se ne sono andati altrove.
Marcella Bitozzi
__________________
(*1) Notizie riportate sui registri dell’ex brefotrofio e depositati nella biblioteca comunale di Osimo
(*2) (La terribile battaglia di Via Vallecchia è stata descritta a pagina 81 del libro “La battaglia di Filottrano” di Giovanni Santarelli
(*3) Dell’episodio del furto del vitello se ne parla nel libro “La battaglia di Filottrano” di Giovanni Santarelli alla pagina 63.
(*4) MEDAGLIA DI BRONZO
Alla Bandiera dei Reggimenti della Brigata Ionio (221° e 222° Fanteria):
“Negli aspri e sanguinosi combattimenti del S. Gabriele (maggio 1917), del Sober e del S. Marco (18-22 agosto 1917), diedero continue fulgide prove di disciplina e di ardimento."
"Nel giugno 1918 sul Piave riconfermarono le forti virtù guerresche dei loro fanti, strenuamente difendendo, contro il poderoso urto nemico, le posizioni loro affidate."
(Boll. Uff., anno 1920, disp. 47)
Entrambi i Reggimenti vennero Decorati dell’Ordine militare d’Italia
Fonte: www.ilfrontedelpiave.info
Un sentito ringraziamento all’archivio di Stato di Ancona ed in particolare al Vice direttore Carlo Giacomini ed alla biblioteca comunale di Osimo ed in particolare a Francesca Egidi per la collaborazione e la disponibilità dimostrati nel reperimento delle notizie senza le quali non avrei potuto scrivere queste testimonianze