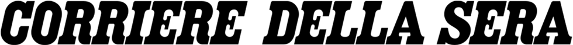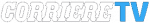Mercoledì 01 Febbraio 2023 ore 09:00
L'OMICIDIO DEL CORPUS DOMINI

di Domenico Simone
. — Il mio debutto nel mondo della carta stampata si può dire che sia coinciso con un fatto storico avvenuto proprio nel borgo dove abitavo da bambino, un luogo tra le montagne, isolato. Sebbene fossi molto impegnato in quel periodo, venni contattato da mio padre, che a sua volta incalzato dal vicino, mi chiedeva se potessi aiutarlo a fare luce su un mistero che era capitato in paese: la scomparsa di una certa Elvira Orlandini, appartenete ad una famiglia di contadini del posto.
Riuscii a ritagliare un po’di tempo e a concordare il dovuto con il caporedattore e mi diressi quindi al paese. Scrutai in fretta case, strade e una rimessa di ricordi dietro ampie vetrate e tetti spioventi. Era davvero delizioso Toiano, specie d’estate, quando si riempiva di turisti.
Iolanda una vecchia ristoratrice che preparava il cibo con la stessa gioia e abnegazione con cui dispensava dicerie, asseriva di un ultimo avvistamento in compagnia del suo fidanzato, un certo Ugo Ancillotti, veterano di guerra, ritornato in licenzia.
Il testimone dell’accaduto, un vicino della vittima, tale Sante Pollastri, figlio di una famiglia romana che aveva preso residenza a Toiano da diversi anni, appresa la notizia della sparizione, si era recato nella locale stazione dei carabinieri, per dare quella che apparve fin da subito la testimonianza più accreditata tra gli addetti ai lavori.
Elvira Orlandini era considerata da molti: la bella del paese. I giorni seguenti la notizia, avvelenarono la vanità delle voci più disparate, ognuna delle quali aggiungeva un particolare ricamo alla storia. Cominciarono a contare storie d’amore intrecciate, alcune anche tragiche che parlavano di violenza e di corna. L’invidia è una religione da queste parti, consola le anime e risponde alle inquietudini più basse, fino a farle credere virtù. E in poco tempo quella laboriosità senza riserve, aveva finito per colorare lo scandalo a patine rosa.
Pochi borghi tra cui quello di Toiano resistevano ancora allo spopolamento per via della migrazione dei giovani verso le comodità e gli agi che forniva un centro cittadino. I due amanti al contrario, avevano deciso di rimanere ad abitare nell’antico borgo situato alle pendici dei monti tra Palaia e Volterra.
Il giorno 5 giugno del 1947, durante la processione del Corpus Domini, nel vicino bosco delle Purghe, fu rinvenuto il corpo senza vita della giovane donna, a quanto pare uccisa mentre attingeva l'acqua da una fonte lì vicino.
La famiglia di Elvira abitava in una casa sepolta in un vicolo vicino alla piccola piazza del paese. Di buon mattino come suo solito, si era recata a fare rifornimento. Passate diverse ore giunta quasi notte, il padre allarmato, si era incamminato per cercarla tra tratti di un luogo brullo pieno di nodi d’albero e intagli di roccia che crollavano di peso sulla vallata. L’immagine emanava una pace perfetta, addirittura una nicchia sacrale. L’uomo crudo, con un giaccone ciancicato di lana da cui spuntava una testa priva di collo, si spinse nel fitto della radura e setacciato il bosco in lungo e in largo, percorrendo il sentiero del Botro della Lupa, un vecchio canale di scolo dismesso, rinvenne il corpo su cui spiccava all’altezza del petto una croce d’oro. Era poco lontano dalla loro abitazione. Il lascito di morte nell’indifferenza, generò una gigantesca faglia di avvilimento nella famiglia.
L'autopsia rivelò che la ragazza era morta a causa di un ampio taglio alla gola, presumibilmente letale, inferto con un oggetto affilato. Al primo colpo ne erano seguiti altri, ma quando ormai il corpo era senza vita.
Ben presto, la direzione delle indagini in capo al maresciallo dei carabinieri della vicina stazione, non ci mise molto ad individuare in Sante Pollastri il colpevole ideale: “Il vicino maniaco.” Era noto alle forze dell’ordine, furono ritrovate in casa sua un paio di mutandine della ragazza celate in un cassetto.
Il paese me lo ricordavo sempre avvolto dalla nebbia d’inverno e tale era rimasto in novembre quando ritornai. Quella massa fumosa alterava i contorni delle cose, scrutava nel freddo mattino, come se quella coltre grigia volesse seppellirlo sotto le sue meschinità, serrato tra una giogaia di colline tutte intorno.
Sempreché continuassi a svolgere il mio compito, avevo bisogno di raccogliere notizie degne di cronaca. La storia stava impegnando le pagine dei maggiori quotidiani e dovevo batterli sul tempo. Chi meglio di me, un indigeno del posto, avrebbe potuto? ma a quale prezzo? Avrei potuto rischiare anche di perdere la reputazione e con che faccia mi sarei ripresentato un domani ai miei compaesani e alla mia famiglia.
Passavo le giornate a rivedere gente che non vedevo da un po’, a guardare vecchie foto di giovani sorridenti che imbracciavano armi, pronti a partire per il fronte e per l’ignoto.
Il giorno lo dedicavo alle indagini ma sempre di corsa per redigere un nuovo articolo per la cronaca nera del mio giornale, aggiungendo magari un particolare, anche orroroso, che mi veniva recapitato da una voce o da dettagli che raccoglievo qua e là. Di questo passo sarei finito col dedicare il mio tempo a scrivere un racconto d'appendice e non una storia che reclamava giustizia. Impegnato da un’attività metafisica, mi toccava il difficile compito di fare chiarezza. Mi era bastato un solo passo su quel terreno per avvertire il legame ancestrale e le radici profonde a cui ero legato.
Mi premeva l’idea di diventare il reporter del momento. Dormivo poco e lavoravo di più, misurando il tempo e l'aspetto con i chili che perdevo di giorno in giorno. Nonostante le nostre vite si svolgessero nel raggio di pochi metri quadrati, io e mia madre non eravamo mai stati così vicini e lontani allo stesso tempo e a non vederci per un paio di giorni. A primo impatto non mi ebbe riconosciuto, con quell’accenno di barba sale e pepe che mi era cresciuta e le occhiaie scavate in un tunnel di carbone. Lei non aveva mai conosciuto quella fame, che non ha niente a che vedere con il cibo, ma che ti erode dentro e fuori. Divenne sua opinione che quell’aspetto cadaverico di lì a poco avrebbe celebrato l’epitaffio che mi avrebbe portato alla morte. Alla fine pubblicavo ogni capitolo malvolentieri, ero snervato e stremato nel corpo e nella mente. Il mio capo redattore lo riteneva un eccesso di morbosità: “Uno sperpero di tempo”, queste furono per inciso le parole usate. Ma considerato il favore dei lettori e l’effetto degli articoli, fu costretto suo malgrado a retrocedere e a tollerare tutte le mie stravaganze. Ben presto il mistero di Toiano portò alla luce il lato oscuro di una piccola comunità lussuriosa, degna di un romanzo. Un luogo più miserabile del dovuto rispetto ad altri, senza bandiere, razze e degno delle schifezze più disparate. Ero troppo preso a guardare dal di fuori, da ignorare il fuoco che ardeva nel focolare.
Considerata troppo intransigente Elvira Orlandini e ancor più contorta e ambigua per essere una popolana, aveva agitato calunnie e oltrepassato la dorsale delle ipotesi, come se indossare le novità più impressionabili in fatto di vestiti e biancheria intima: calze che incendiavano fantasie, avidità e grettezza, bastassero per formulare un’etichetta e officiare la condanna ad amante del secolo.
Con il tempo sembra che le fosse diventato troppo stretto quel mondo: la dimora, i pettegolezzi, l’eterna attesa del suo amato e l’ira del padre, erano un impegno logorante, tanto da farle maturare la voglia di evadere, di scappare da quel posto. Ma il padre si era accorto del suo smarrimento e aveva iniziato a tenerla segregata in una stanza nel seminterrato della casa, popolato perlopiù da ragni e topi. In seguito, la permanenza in quel posto logoro mise a dura prova la psiche della donna, già molto provata. Elvira aveva escogitato un metodo per passare il tempo, facendo diventare i piccoli animali, macabre reliquie coperte da ragnatele per il suo trastullo, utilizzando le bacchette avvelenate che le forniva la madre, paralizzavano i muscoli del corpo dei piccoli esserini, prima che questi si avviassero verso un lungo calvario che li avrebbe portati ad una morte silenziosa. Ciò non sortì l'effetto sperato, non la distolse mai dai propositi di fuga, anzi, accrebbe ancor più in lei quel pensiero, diventato una valvola incendiaria pronta per esplodere.
La patologia che affligge il genere umano ha un nome, si chiama: invidia e sembra che abbia intelaiato il dramma con aspirazioni, amore e fuga. Da lì in poi la ragazza perde l’autocontrollo e termina per cadere in un baratro che le fa perdere la ragione.
Segretamente in passato avevo finito anch’io per accarezzare l’idea di amore per quella donna, l’avevo idealizzata. Era bellissima, da far perdere la testa, con quei suoi lunghi capelli color corvino che le cadevano a ciocche su una pelle ossigenata quasi diafana. Mai avrei ipotizzato che quei pensieri segreti sarebbero finiti in parole proibite che avrebbero coltivato le pagine di un giornale.
Anche se la mia presenza non sembrava essere granché gradita quando mi presentai in casa sua, il padre mi invitò comunque ad entrare. Era consumato dal dolore, quanto la moglie dal pianto. In principio fu restio a farmi entrare, il mondo intorno a lui era stinto e i contorni delle cose sbiaditi, fece largo con un braccio e seguii l’indirizzo di quel gesto. Demmo un’occhiata alla stanza della figlia, profumava ancora di un'essenza di lavanda, si scoprì essere il profumo che abitualmente usava. Ne ebbi la certezza quando annusai un boccettino che teneva su una toletta per il trucco. Attraverso il lucernario attiguo al soffitto si sentivano i rantoli di un gatto che sfiniva i resti del pollo, facendo diventare la casa una tormenta di rumori sinistri. L'unica via d'uscita per scappare, era il sentiero che scantonando di lato portava fuori dal paese e scendendo giù verso le colline arrivava fino al fiume, lo stesso che costeggiava il bosco. Avevo provato a puntare i piedi per entrarvi, ma il terreno in quella stagione era ridotto ad una fanghiglia che si sgretolava solo a toccarla, non era proprio l’ideale per i miei mocassini in camoscio. Mi feci prestare un paio di stivali da mia madre e mi inoltrai nella radura. C'era poca luce, la strada era in aperta campagna e a quell'ora cosa avresti potuto trovare, se non un baluginio di luci che filtravano tra un fitto di rami. Il luogo del ritrovamento non portava alla fonte d’acqua, ma era impossibile mantenere il sentiero evitando di sbattere o imbattersi in uno di quelli più appuntiti e affilati che spuntavano tra felci o di finire in un inghiottitoio di erbacce affastellate a mazzi. Ma come era riuscita ad arrivare fin dove era stata trovata e a divincolarsi in quella selva? Stavo maturando l’idea che ci fosse stata portata per sviare le indagini. Non avrebbe avuto il fegato di scappare, di allontanarsi dalla sua abitazione, ci aveva anche provato, e forse ci era anche riuscita, sicura in principio che arrivata al capanno oltre il sentiero, avrebbe guadagnato la libertà. Ma le Mani l’avevano raggiunta, le avevano cinto le spalle, lei aveva cercato con ogni modo di divincolarsi, per un attimo forse ci era riuscita, ma poi erano arrivate nuovamente e più decise ad afferrarla per scaraventarla al suolo.
In poche settimane vidi come l'orgoglio ferito di coloro che fino a poco tempo prima avevo considerato una grande famiglia, si erano trasformati nel bigottismo della santissima inquisizione. C’era chi iniziava a togliermi il saluto, la parola e si compiaceva nell’affilare quel risentimento, con un talento inimmaginato nel rivolgere i peggiori improperi alle mie spalle. Si stava diffondendo quel paradigma conveniente per cui, per guadagnarsi il favore altrui bisogna assecondare il favore della folla, senza eccezioni. Davanti alla piega degli avvenimenti, iniziavo a sospettare che i miei giorni in paese fossero contati. Il ventaglio di antipatie che i miei sforzi si erano procurati, non facevano che aumentare le resistenze e la riuscita del mio lavoro.
La casa circondariale di Firenze si trovava fuori alla città. Era il classico monolitico di cemento a pianta squadrata, circondato da un reticolato di ferro. All’interno l’afrore pestilenziale ammorbava l’aria. Sante Pollastri non si aspettava una mia visita, fu molto sorpreso quando mi vide. L’ultima volta che ci eravamo incrociati forse ero un bambino che non riconosceva da adulto.
Nella sala interrogatori si palesò un uomo sulla sessantina con i capelli unti avvinti sulla fronte, una corporatura tozza che con la vecchiaia invece di sfiorire di massa grassa, sembrava si fosse limitata ad assestargli delle rotondità ancor più solide nei fianchi compatti. Il massimo che feci, fu di tracciare un profilo basso, e goffo: uno che poteva arrivare a rubare, ma non ad uccidere. Una volta vicino al vetro, tirò su gli occhiali da miope per squadrarmi ancora meglio, forse per trovare riscontro in qualche somiglianza, ma niente. L’espressione che ne veni’ fu di rimanere inchiodato inerte sulla sedia e di continuare a studiarmi. Era il bersaglio facile. Ad ogni domanda si limitò a rispondere alzando lo sguardo e allargando le mani. Imparai che nella vita quasi tutto si dimentica, ma non l’onore. Nei momenti tristi e furono in maggioranza in quel periodo, in quella conversazione mi chiesi più volte, fin dove si potesse spingere la miseria umana.
Ma appena uscito da quelle quattro mura, il mio primo proposito fu quello di andare fino in fondo, volevo tirare a tutti i costi quell’omino fuori da quel tugurio e farlo il prima possibile. Ma tirava una brutta aria e a qualcuno prudeva l'anima di convalidare quella scelta sciagurata.
Elvira e la madre la domenica alle undici cascasse il mondo all'ora della messa, partivano di gran carriera per il loro appuntamento settimanale con il Supremo. Il padre approfittava della loro assenza per separare le bestie nella stalla, svuotava gli orinatoi, rimpinzava la paglia. L’uomo infelice, si chiamava Teclo, da giovane aveva aspirato a diventare un gendarme della milizia. Non potendo, aveva ripiegato sul servizio alla famiglia e sulle cronache borghigiane, da cui nemmeno lui stentava a sottrarsi.
Ah se gli avessero dato le possibilità di suo fratello Aroldo, ora non sarebbe qui a spalare letame, caricarlo e rovesciarlo nei terreni. Dopo il sermone settimanale arrivava il pranzo della domenica, ammucchiati intorno alla tavola davanti alla finestra enorme della sala, i residenti potevano consumare un pasto più appetibile che in altri giorni della settimana. Si trattava semplicemente di aggiungere alle classiche verdure e patate, dello spezzatino di carne. Sentire i mugugni del padre che emetteva nel fagocitarlo, accendeva di soddisfazione il viso della consorte. Marco il secondogenito, soprannominato il Balilla per la parlata piccante capace di scagliare sassi tanto fossero lapidarie le sue sentenze, si guadagnava la vita facendo il calzolaio di mezza tacca ed aiutando il padre nei campi. Ma la sera e le feste comandate le riservava al suo passatempo preferito: la filatelia, che praticava di nascosto dal padre convinto Fascista e contrario ad ogni trastullo. S'impegnava con brio nella ricerca dei francobolli, se ne stava rinsaccato su sé stesso alla finestra, nell’attesa che una missiva potesse arrivare da un momento all’altro. Osservava ogni pezzo dalla sua angolazione con fissità, come se volesse stampare a mente la linea sinuosa della merlatura, i fianchi e i colori accesi o spenti del tratteggio.
Allorché si allontanava dalla luce e stringeva l’intero involto a sé, lo coccolava tra le braccia, con una rara forma di amplesso. I due corpi si fondevano in un tutt'uno di sentimenti ed effusioni.
Quella stranezza era padrona solo dell’occhio indiscreto e amorevole di una madre che perdona tutto.
Quando rientrai in casa un pomeriggio che mi ero sbrigato prima, mi imbattei in una visione insolita, Ugo Ancillotti era seduto intorno al tavolo della cucina a chiacchierare con mia madre. Era tutto lui, con la divisa elegante e sorrideva con un filo di denti smaccatamente falso. Non mi sentirono entrare, lo osservai attentamente da lontano, ma avevo già deciso che quel tipo non mi piaceva.
Si soffermò più volte ad osservare la casa, come se cercasse qualcosa, e sospirava con disgusto. La casa era umile sì, ma non poteva essere oggetto di un sentimento immotivato. Mi feci strada quatto, rivelandomi alla sorpresa di entrambi, che non mi avevano sentito arrivare. Entrai e chiusi la porta. Dopo aver dato un'occhiata veloce agli incartamenti che avevo lasciato sulla credenza della sala, mi avvicinai per fermarmi al centro della stanza e lo guardai con freddezza. Non faticavo ad immaginare ciò che pensasse. La vita aveva benedetto quel ragazzo con molti talenti, fra tutti quello di saper mentire. La giacca emanava un profumo di lavanda, lo stesso che avevo per inteso percepito in casa di Elvira, è lì che mi nacque il sospetto, ma anche il fatto che fossero giorni che era in paese e non era ancora rientrato in caserma, in genere ricevevano solo tre giorni di licenza. Continuavo a sezionare con cura ogni gesto e parola, pronto per la disamina. Vederlo fraternizzare con mia madre fu una delle cose più sgradite che potessi accettare e non mi aiutava ad essere lucido. Ma quando mi ordinò di porgergli un bicchiere di acqua senza usare cortesia, fu il culmine dello sproloquio. Mi rivolse un sorriso che metteva in chiaro l'ordine delle cose senza bisogno di parole. Lui rappresentava il potere e io ero la sudditanza e capii che anche se avessi trovato tutte le prove per incriminarlo, sarebbe riuscito a farla franca. Assaporò l'acqua con un gorgoglio, con quel fare aristocratico, come se l’acqua avesse sapore. Avrei voluto aggiungere qualcosa che gliene desse, ma su consiglio della mia coscienza fui costretto a desistere, facendo morire d'asfissia il mio orgoglio ferito. L’ombra del colpevole era lunga, e per quanto la mascherasse, quel ragazzo ostentava con grazia da scapigliato la sua innocenza, una propaggine che non consentivo.
La villa dove abitava, era piena di scalinate e abbaini. Ogni giorno una splendida ragazza si recava nell'abitazione per pulire, cucinare e stirare tutte le esistenze balorde di quella casa, in perpetuo oblio. Al rampollo gli era stato severamente proibito di frequentare persone di rango minore. Ma lui intransigente e scapigliato quale era, aveva fatto incetta delle raccomandazioni, se non poi fare l’esatto contrario. Non che il fascino della ragazza non lo avesse rapito, ma fu più un gesto di eversione verso il dovuto diritto. Si alzò e si mise a camminare per la stanza senza aprire bocca, si avvicinò alla finestra soffermandosi a guardare l'esterno, che doveva essere ancora più riprovevole che l’interno, vista l’espressione schifata che gli affiorò.
Era mosso dalla curiosità di vedere dove abitasse il famoso scrittore. Strinsi nelle spalle. In quanto educato e amante della buona creanza introiettami, feci finta di nulla. Estrassi una sigaretta dal pacchetto di Nazionali senza filtro e la accesi, il fumo confondeva in qualche modo pensieri ed espressioni. Fu un gesto istintivo, mia madre non lasciava fumare nessuno in casa, ma aveva intuito il mio malumore. Ne offrii anche una a lui che accettò prontamente e che accese.
La verità è che da un po’di giorni non avevo granché più da raccontare su quella storia, mi lasciai quindi impressionare da quel tipo, cercavo di carpire ogni curiosità e ne aveva tante. Gli amorazzi da adolescente che descriveva con dovizia di particolari, non erano frutto di fantasia, si stava raccontando con la sfrontatezza dell’uomo che sa di essere intoccabile, con ciò si autoconsacrava a maestro della divina arte amatoria. Mia madre lo guardava perplessa, con lo sguardo bonario di una persona umile che non sa discernere. Fatto sta che ci fosse quasi certezza in ciò diceva e nella sfilza di leggende fiorite tra la gente, ricamate intorno ad un carattere libertino. I miei occhi vagavano da un punto all’altro, scrutando attentamente, solo quando focalizzai lo sguardo, riuscii a vederlo sempre più nitido, finché non fu inequivocabile, la sfrontatezza e maleducazione, che nemmeno davanti ad una donna di mezz’età riusciva ad eclissare. Rilevavo una certa spocchia in quelle parole, ma dubitavo che se ne rendesse conto. Io che avevo dedicato la mia vita ad un solo amore, che fosse la nobile arte della scrittura, ero considerato alla stregua di un arido mollaccione al suo cospetto. Così mi definì. Sbuffai, lui inarcò un sopracciglio, ma sopravvenne a quell'intemperanza. Venirsene fuori adesso con tutte quelle storie di amori che arrivavano solo al cuore delle persone più pavide, avevano un gusto perverso. Il mio momento di innamorarmi non arrivava mai, è che non avevo voglia di affidare la mia vita a qualcuno che non conoscessi approfonditamente, ciò richiedeva un impegno che non potevo sostenere, visti i miei tanti che avevo date le continue uscite fuori porta. Ogni desiderio per questo evaporava più in fretta dell'intenzione. Vicino ai trenta piuttosto che ai venti anni, mi accorgevo che il tempo stava passando e non ero più giovane. Il mondo è dove tutto deteriora, a cominciare dalla bellezza per finire con la memoria. Ero uno dei pochi senza contare forse quei poveracci dei suoi commilitoni, costretti ad ascoltare quel simposio di orazioni con cui voleva omaggiare le nostre orecchie. Fui sorpreso con le mani nel sacco in un’espressione poco convinta, sospirò digrignando i denti e masticando le ultime parole. C’era una rabbia iniqua nei suoi occhi, che non lasciava scampo, un remoto furore più vicino agli inferi, che alla Grazia Divina. Per ultimo ebbe lasciato la pietanza più succulenta, asserendo che la povera Elvira, sperava nel matrimonio. Temeva di essere rimasta incinta. Timore che aveva confidato alla sedicente maga Bongiorni, specialista in problemi di cuore. Voleva sistemarsi e quale partito migliore se non un uomo ricco. Per tale motivo si era trovato costretto a lasciarla e la cosa le aveva spezzato il cuore. Aveva la memoria di quelle parole incisa in una faccia da bronzo. Mi sorrise, lustrò le labbra con la lingua lasciando una cromatura di saliva che brillò sotto la luce, come se fosse il riflesso marmoreo di una scultura. Elvira, pensai che avesse attraversato fin troppi giorni di sventura in compagnia di un individuo del genere e che la sua dipartita fosse più ascrivibile ad una benedizione dello Spirito Santo che ad una sventura. Quel ragazzo era niente, quanto al cinismo che apre le porte al potere. Avevo sentito dire da qualcuno dei domestici della Villa Ancillotti, di essere stato visto in compagnia di Elvira quel fatidico pomeriggio e trascorso un po’ di tempo nel giardino di casa. Poi li avevano visti allontanare a piedi presto, per recarsi nella piccola piazzetta del paese e da lì erano finiti entrambi a passeggiare lungo l’argine del fiume.
Era l’unica famiglia a possedere una delle prime automobili in circolazione che fino a quel tempo in paese erano state avvistate solo sui giornali di rivista. Mi girai e mi trovai di fronte ad un’espressione machiavellica che le batteva tutte, mentre si dirigeva verso la porta, ci salutò da lontano solo quando vi fu vicino e ricambiammo d’obbligo.
Seduta in macchina fuori, cosa che non avevo notato entrando nel cortile di casa, forse perché distratto da un fiotto di piante tutte in fila, scorsi una signorina, era seduta nel sedile passeggero, la riconobbi subito in Regina Terruzzi, figlia della governante di Villa Ancillotti. Creatura divina, dalla pelle candida, le labbra pennellate di rosso, ragazza fine dagli occhi azzurri limpidissimi, era caduta anche lei senza eccezione di colpi, nelle sue spire. Più piccola di Elvira di almeno un paio d'anni, toglieva il fiato solo a vederla.
Mi affacciai alla finestra e li vidi allontanarsi con la macchina, il motore dispiegò nell'aria una sinfonia di pistoni e una nuvola di fumo. In quell'istante la figlia della governante alzò gli occhi e guardò verso la nostra casa. Le sorrisi e la salutai, anche lei accennò con una mano guantata, un attimo dopo distolse lo sguardo e la vettura si allontanò per far ritorno al mondo dell’opulenza.
Ed ero finito per chiedermi se fosse una giusta causa quella che stavo percorrendo. Ma sentivo di dover fare qualcosa per difendere l’onore vilipeso di quell’angelo troppo presto volato in cielo. Cominciavo a sentirmi il più fortunato dei mortali quando scoprii che l’assassino portava il volto e le cicatrici di una guerra che grazie a Dio e al giornale avevo solo sognato e redatto.
Decisi di passare all’azione, volevo convincere l’uomo ad autodenunciarsi. Era necessario farlo in posto acquattato, per limitare la presenza della gente. Quando gli arrivai alle spalle, lo colpii con un randello, né sangue, né un’escoriazione, gli ebbero segnata la testa. Gli avevo tirato un colpo da manuale, di quelli che ti tramortiscono e non ti lasciano il fiato. Era diventato pallido e in men che non si dica, cadde al suolo come un sacco pieno di carbone.
Riuscii a farlo confessare con un espediente, fingendo di mettere tracce del profumo di Elvira sulla divisa, più quelle del suo sangue. Ciò lo indusse a confessare che in un drammatico confronto corpo a corpo, dopo aver organizzato una passeggiata con la collaborazione della sua nuova amante: Regina Terruzzi avevano progettato di ucciderla.
Pochi giorni dopo il veterano di guerra venne accusato dell’omicidio di Elvira Orlandini. Venne scortato di forza a Firenze contro il volere dei compaesani, ma subito rilasciato per mancanza di prove e dichiarato alla fine innocente.
Dava fastidio che l’idea che il beniamino del paese, ufficiale dell’esercito, potesse essere etichettato come il responsabile. A complicare la cosa, ci fu l’ostracismo di una parte di stampa faziosa, smaccatamente schierata con il regime. Mentre loro sfinivano in aspirazioni e ambizioni letterarie che languivano le pareti flaccide del Duce, i lettori che si aspettavano un risvolto eclatante, assaporando l’idea della sua colpevolezza, forse soffrendo dello stesso mio dismorfismo, leggevano con avidità i miei articoli, rincuorati da questo, ma rassegnati nell’apprendere i modesti sviluppi sulla vicenda.
______________________-
L’omicidio del Corpus Domini è stato realizzato da Domenico Simone, alla fine del Corso di scrittura dal titolo Storie a tinte gialle, promosso dalla Fondazione Peccioli per l’Arte e condotto dal giornalista Andrea Marchetti presso la Biblioteca Fonte Mazzola
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI