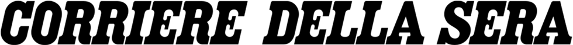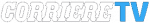
Nel Para Ice Hockey esiste il fuorigioco? Otto curiosità sullo sport più elettrizzante delle Paralimpiadi invernali

Sabato 01 Aprile 2023 ore 09:00
IN CADUTA LIBERA

di Vittoria Giaganini
PECCIOLI — Quel giorno iniziò molte ore prima dell’alba, e il primo rintocco delle campane fu sostituito da un grido d’aiuto. Il figlio del calzolaio stava risalendo Via Carraia dopo una serata con gli amici quando una macchia scura offuscò il cielo stellato, prese la forma di un essere umano vestito di nero che volteggiava in aria e precipitava sul lastricato di Piazza del Popolo come un’aquila in picchiata verso la preda. Il giovane che aveva assistito alla caduta si mise ad urlare, svegliando tutto il paese, e svenendo un minuto dopo l’arrivo dei primi soccorritori. Era la notte tra il 15 ed il 16 settembre 1979 quando la quiete di un borgo arroccato sulle verdi colline della Valdera fu squarciata dalla morte di un giovane sacerdote, precipitato dal campanile.
Tutti avevano la propria versione della storia. Italo del bar sotto le logge diceva che per lui si trattava di suicidio. Allora sua moglie Pasqualina, con le braccia da massaia e gli occhi spauriti, lo colpiva col giornale alla nuca dicendo che nessun cristiano avrebbe potuto ripudiare il dono della vita, tantomeno un prete. Questa scenetta attirava i passanti, che si riunivano al tavolino a discutere sul come e sul perché. Qualcuno buttava un’ipotesi di incidente, qualcun altro sosteneva che si trattasse di mafia, altri ancora parlavano di punizione divina. Perfino Lucio, un instancabile vecchietto che aveva perso un braccio sotto un cavallo, partecipava con passione alle discussioni al bar; il problema è che diceva sempre cose senza senso e nessuno gli dava retta. Si dice che un anno, poco prima di Natale, Lucio era stato trovato in fondo a Via dei Cappuccini, con gli occhi stretti e la bocca aperta che borbottava “Se ‘un ci vo io nei campi, quest’anno addio ciliegie!”. Tutto sommato era innocuo, anzi, la sua presenza animava molte serate al bar, come quella dove tutti si erano messi a discutere della caduta del prete. Pareva una partita a carte alla quale tutti volevano partecipare, però senza il bisogno di vincere.
Intanto, il vecchio parroco scappò in un’abbazia dell’Umbria, il campanile e la chiesa vennero chiusi e la gente cominciò a dare di matto perché senza le campane il tempo non aveva più senso e il sole sorgeva e tramontava indisturbato, dietro ad una collina dove contadini ed operai non si erano mai sentiti così vulnerabili. Uscirono le prime notizie. “Tragedia in un borgo toscano: ipotesi di omicidio” leggeva a bassa voce il giornalaio, fissando timoroso quella parola che nessuno voleva pronunciare. Tra tutte le storielle che circolavano sul povero prete precipitato dal campanile, nessuno osava contemplare la possibilità che ci fosse un assassino tra loro. E anche i carabinieri, che fino a quel momento si erano occupati di furti e scorrerie di ragazzini indisciplinati, non volevano credere alla gravità della situazione. Così vennero a chiamare me, che appena avevo ricevuto la notizia del presunto omicidio mi ero barricato in casa ed uscivo solo all’alba per portare fuori il cane. Mia moglie a quel tempo lavorava ancora, e mi riportava i discorsi che circolavano in paese e sui banchi di scuola. “Sembra che si siano finalmente degnati di riconoscermi” sbuffò una volta, tornando dal mercato. “Adesso mi salutano tutti e chiedono “Oh Berta! Ma il su’ marito che ne pensa? ‘Un era un poliziotto?”. Lei, che quando ero entrato nel Commissariato di Porta S. Giovanni mi aveva tenuto il muso per una settimana, sopportava meno di tutti l’idea di un simile misfatto nel paesino dove aveva sempre sognato di vivere.
Io e Berta ci eravamo conosciuti durante la mancata difesa di Roma, quando gli sfollati si ammassavano nelle case più grandi, come la mia. Io ero un fortunato, dicevano, perché la disgrazia mi era già capitata: mio padre era morto durante la prima guerra mondiale, poco dopo la mia nascita. Così vent’anni dopo fui l’unico a rimanere a casa con la madre vedova assieme ad una decina di altre donne del quartiere. Tra queste c’era anche una ragazzina con le ginocchia sbucciate, Alberta, figlia di una coppia di partigiani dei quali nessuno sapeva niente. Ci siamo sposati nel ‘52, il giorno dopo la fine delle magistrali. Lei ha iniziato a lavorare in una scuola subito dopo, e io sono entrato nel Corpo di Polizia. Abbiamo vissuto per quasi vent’anni la ripresa economica con ottimismo, convinti che tutti avessero sotterrato l’ascia di guerra. Poi comprammo la televisione e ci crollò il mondo addosso. Arrivarono le notizie del Vietnam. Poi delle proteste studentesche. E infine della strage di Piazza Fontana. Finché non ci siamo trasferiti a Peccioli, poco dopo l’omicidio di Aldo Moro, né io né mia moglie siamo riusciti a dormire una notte intera. Roma era diventata troppo ostile, con un allarme bomba ogni settimana, con una protesta ogni due giorni e una sparatoria ogni mese. E io, che arrancavo dietro a tutta quella violenza cercando invano di contenerla, non ressi il colpo. “Andiamo via, Romolo” mi scongiurò Berta accanto al mio letto d’ospedale dopo l’infarto. “Tua zia in Toscana può darci una mano”. Così richiesi la pensione anticipata e partimmo alla volta del paesino originario di mia madre. Trovammo finalmente il nostro angolino di paradiso, ma la vacanza fu breve.
Durante la mia passeggiata al fiume insieme al mio bastardino, una settimana dopo il misfatto, mio cugino sbucò dalle frasche. Mi fece saltare dalla paura, perché in quell’atmosfera bucolica ai piedi di Peccioli al massimo si poteva incontrare Lucio, preso da qualche conversazione con se stesso. Invece vidi proprio Giovanni, un contadino sulla quarantina con lo sguardo rude di chi preferisce parlare alle mucche piuttosto che alle persone. Mi disse che i carabinieri mi stavano cercando. Allora tirai un bel respiro, pronto ad accettare il mio destino. Giovanni mi accompagnò in caserma e cominciò a raccontare della mia ammirevole carriera da commissario. “Allora Dotto’, che ne pensa?” lo interruppe il Maresciallo. In men che non si dica, mi ritrovai ad una scrivania a leggere verbali e testimonianze. Ovviamente mia moglie non fu felice quando le dissi che avrei dato una mano a risolvere il caso di presunto omicidio. Quella sera mi congedò con poche e dure parole “Guai a te se ti fai venire un altro infarto”.
Passai un giorno intero a recuperare tutto il lavoro che era già stato fatto. Il Maresciallo Cioni
mi diede una scrivania davanti al suo ufficio, così che lui potesse tenermi sotto controllo. Era un tipo poco più giovane di me, che non sorrideva e che non si toglieva mai il cappello della divisa. Mi porse i fascicoli del caso senza lasciarli andare e mi rivolse un’occhiata seria come a dire “questo rimane tra noi”. Poi li lasciò cadere sulla scrivania e io li lessi con cura. Dall’analisi della scena del crimine mi rimase impresso un solo dettaglio, anzi due. Un bottone grigio era stato ritrovato sotto il corpo di Don Giusto, in Piazza del Popolo, identico a un altro individuato dietro l’altare della chiesa. Sebbene indossasse ancora il talare nero al momento della morte, quei bottoni non appartenevano agli abiti della vittima. Quindi mi appuntai su un quaderno un primo punto interrogativo: chi ha perso quei due bottoni? Ma soprattutto, cosa ci fa un prete in cima al campanile in piena notte? Così lessi la deposizione del vecchio parroco, Don Fausto, il quale aveva accolto il giovane sacerdote come suo assistente pochi mesi prima, notandone una particolarità. Don Giusto passava molte notti nella pieve di S. Verano, in segno di completa sottomissione. “Dopo cena prendeva il suo taccuino dove scarabocchiava qualcosa per l’omelia ed entrava in chiesa passando dal nostro corridoio che porta da un lato alle scale del campanile e dall’altro all’abside. E lo vedevo poi la mattina che aveva la schiena tutta torta: non ci si dorme mica bene su quelle panche!” aveva detto il parroco ai carabinieri prima di lasciare Peccioli. Mi colpì quel verbo: “scarabocchiava”. Di solito si usa per descrivere i disegni di un bambino, non gli appunti di un’omelia. Terzo punto interrogativo: Don Fausto nutriva del risentimento per Don Giusto?
Infine passai in rassegna il verbale di perquisizione della stanza della vittima e del campanile. Il Maresciallo mi ci volle accompagnare, nonostante io avessi specificato più volte delle mie vertigini. “Dotto’, ma ci vuole aiutare o no?” aveva chiesto lui, uscendo dalla caserma senza nemmeno aspettare la mia risposta. Risalimmo il paese a piedi, scavalcammo i nastri che coprivano il portone esterno del campanile, attirando sguardi dei clienti al bar delle logge, ed entrammo nel corridoio descritto dal parroco. Nello spazio buio e umido si vedevano a malapena la porta per la canonica, a destra, e quella per la chiesa, a sinistra; davanti a noi poi si ergevano le ripide scale a chiocciola. Deglutii e seguii i passi del Maresciallo in silenzio. “Crediamo che Don Giusto sia precipitato dal terrazzamento della guglia. Qui avrebbe dovuto spostare le campane, che avrebbero suonato, e l’unica cosa che si è sentita quella notte è stato l’urlo del ragazzino” disse una volta in cima. Tirava vento e cercavo di aderire il più possibile al tetto di mattoni. Il Maresciallo si appoggiò al muretto e guardò giù, preoccupato. “Secondo lei chi è stato, dotto’? Per un commissario come lei questa è roba da poco”. Io cercai di calmarmi e risposi, balbettando, che era troppo presto per saltare a conclusioni, ma nutrivo dei sospetti per l’altro sacerdote, Don Fausto. “Lui era in canonica con la perpetua quella notte, infatti sono stati i primi ad aiutare il ragazzino. La signora Claudia è stata interrogata ieri, ha detto che da un po’ di tempo non riesce a dormire, quindi va dal parroco e pregano insieme finché non sale il sonno” rispose lui ed io tirai subito fuori il quaderno dove provai ad appuntarmi qualcosa. “Non c’è niente di cui preoccuparsi su questi due, Dottore. Le sento le voci di paese: nessuno ha mai insinuato nulla su quella povera vedova e Don Fausto. Anzi, credo proprio che il movente di gelosia o passione sia da scartare”. “Allora è sicuro che si tratti di omicidio?” chiesi io, e il Cioni si girò a guardarmi coi suoi occhietti severi, annuendo. “Per denaro o per vendetta, il prete qualcuno l’ha ammazzato”.
Tornammo in caserma e lessi anche la deposizione della perpetua, fresca di battitura, e mi appuntai la quarta domanda: perché una donna pia e vedova non riesce a dormire la notte? Poi mi accasciai sulla sedia e guardai verso il tramonto oltre la finestra.
Se davvero il movente passionale poteva essere scartato, allora c’era da indagare sulla vita privata della vittima. Ma Don Giusto era arrivato da poco, non aveva familiari né impegni fuori la chiesa. Nella sua umile stanza non era stato trovato nulla di sospetto. Teneva un registro delle spese quotidiane: sembrava non avesse debiti. I carabinieri avevano già sentito le suore e alcuni bambini dell’oratorio: tutti lo consideravano a posto, buono e gentile. Anzi, c’era chi lo preferiva a Don Fausto perché le sue messe erano meno lente e noiose.
Mi stropicciai gli occhi e chiusi i fascicoli sulla scrivania, facendo cadere due fotografie. La prima era la copia della carta d’identità di Don Giusto, e la seconda una foto tessera di Don Fausto. Notai per la prima volta che entrambi portavano gli occhiali ed erano magri e di media statura. Se poi si considera che si vestivano nello stesso modo, qualcuno li avrebbe potuti scambiare per fratelli.
Di tutti e quattro i punti interrogativi che solleticavano i miei pensieri, decisi di risolvere quello che mi sembrava più semplice. Infatti, dopo che mia moglie aveva trovato la Signora Claudia in farmacia che litigava col commesso per farsi dare dei calmanti senza ricetta, cercai il suo indirizzo sull’elenco ed andai a trovarla. Abitava in una di quelle casette arroccate dietro Via Roma, dove il pendio della collina è segnato da una passeggiata sullo sfondo delle Serre. Vidi la sua facciona rossa spuntare dalla finestra del piano superiore. “Che volete?” chiese socchiudendo gli occhi. Io sfoderai un sorrisone e le dissi che avevo bisogno di confessarmi a Don Fausto ma nessuno sapeva quando sarebbe tornato. “Abbia pazienza, gli serve una pausa, dopo quello che è successo a Don Giusto, pace all’anima sua! Venga in casa, preghiamo insieme” rispose lei. Entrai in questo monolocale buio e freddo, mi sedetti su una sedia cigolante e recitai due Ave Maria prima di poter proferire parola. Le chiesi del parroco e lei si irrigidì. “Io non dico male di nessuno, signor Giordano! Però senza prete questo paese è perso… Capisco che deve riflettere, che la tragedia di Don Giusto lo fa stare male. Ma io, signore? ‘Un c’ho da fa’ nulla! Noi” disse prendendomi le mani “noi come si fa?”. Distolsi lo sguardo per alleggerire la tensione e vidi una vecchia fotografia al muro. “Guardi che bello ir mi marito quand’era nei su’ panni. E’ morto sotto un trattore, pace all’anima sua, proprio di questi tempi. Infatti io come ogni anno non riesco a dormire a settembre, quando riparte il lavoro e le giornate s’accorciano”.
Se c’è una cosa che ho imparato in 25 anni di indagini è che quando si è trovato l’argomento prediletto di una persona la si deve far parlare. Poi la verità fiorirà da sé.
Così la signora Claudia mi raccontò di questa famiglia Cini che nel dopoguerra aveva acquistato molti terreni da chi era rimasto senza un soldo e aveva dato da lavorare a tanta gente, come suo marito. Anche se gli affari andavano bene, il figlio, chiamato “Barone Cini”, pareva insaziabile. “Volevano tutti lavorare per lui, perché di terra ce n’era rimasta pochissima. I maiali ce li aveva tutti lui, il grano, i girasoli, c’aveva tutto, Signor Giordano. Gli uscivano i soldi dalle orecchie, al Barone, e trattava i dipendenti come bestie. E’ per questo che poi tanti sono andati a lavora’ fuori, in fabbrica, perché qui se volevi fa’ il contadino dovevi fa’ lo schiavo per lui” disse Claudia d’un fiato. Allora le chiesi che fine avesse fatto questo Barone Cini di cui io non avevo mai sentito parlare. “E ci credo! E’ vent’anni che non mette piede in paese. Sta rintanato nella su’ villa accanto alla fattoria, che ora è diventata una confezione. Non lo sapeva? Laggiù verso le Serre, ora c’è una ditta di cappotti. Dopo aver ammazzato i contadini fa lavorare le sarte…. Signore Mio dammi la forza di sta’ zitta!”. Mi avvicinai alla finestra che dava sulle colline: in fondo ad una valle notai per la prima volta un edificio fumante. “E quindi ha rivenduto i terreni?” chiesi io. “Certo, e a che prezzo! Non sa quanta brava gente s’è indebitata con lui solo per riave’ un pezzetto di terra grande come casa mia! Anche il parroco c’ha avuto problemi! Che poi io ‘un dovrei di’ nulla perché Don Fausto e il Barone so’ cugini”. Mi voltai di scatto. “E tra loro scorre buon sangue?”. “Il barone non si farebbe amico nemmeno uno scemo come Lucio, quello storpio. Detto tra noi, Signor Giordano: Don Fausto aveva ereditato dalla madre qualche milione di lire, che voleva lasciare alla parrocchia, sia chiaro, ma il barone lo ha sempre spinto ad investire nella ditta, qualche anno fa, lui e i su’ ruffiani che gli stanno d’intorno. Però Don Fausto non gli ha mai dato un centesimo e dopo un po’ quello lì non ha più insistito. Ora è troppo occupato a gestire gli scioperi. Gli affari non gli vanno mica tanto bene, eh. Da casa mia li vedo sempre i camion con la merce che torna indietro. Ci so’ troppi difetti di fabbrica in quei cappotti”.
Quella sera non avevo fame. Ero colto da una vecchia sensazione dolce-amara che mi saliva quando mi sentivo ad un passo dalla soluzione. Infatti non solo avevo risolto il mio quarto quesito (cosa tormentava la perpetua?) ma mi pareva di aver trovato anche qualche parola per rispondere agli altri tre.
Così uscii a fare due passi e presi un amaro al bar sotto le logge, dove un gruppetto di signori stava ridacchiando. Tra questi c’era anche Lucio, che però era silenzioso, con lo sguardo alienato, in piedi al bancone. Quando Italo mi porse il bicchierino gli chiesi di raccontarmi qualcosa sulla ditta di Cini, con la scusa che dovevo comprarmi un cappotto per l’inverno. Gli altri uomini si girarono subito. “Si vede che è forestiero. I cappotti del barone se li mettono solo i su’ cagnolini. Ci lavorava anche la mi’ moglie, poi quer figlio di bona donna l’ha licenziata per risparmia’” mi disse un signore panciuto tirando dal sigaro. “Eh ma vedrai che ora ci si mette di mezzo il sindacato…” rispose un altro, tirando una carta sul tavolo e provocando qualche imprecazione. Si avvicinò Lucio che alzò la sua unica mano per richiamare l’attenzione e disse con solennità: “Il barone, i maiali, li fa sgozzare a quell’altri”. Tutti risero e anche a lui scappò un suono stridulo che sembrava quello di un bambino. Poi trascinò il suo fragile corpo fuori dal bar e Italo reagì al mio sguardo confuso scapeggiando. “Lo lasci perdere. Saranno dieci giorni che gli è presa la fissa per ‘sti maiali. Quello lì non dorme mai, vede e sente tutto ma ‘un capisce niente”. Lasciai qualche lira sul tavolo ed uscii di corsa. Raggiunsi Lucio per la Carraia e gli porsi una domanda diretta, ansimando. “Il barone ha ammazzato il prete?”. Lui si fermò, rise ancora come poco prima e fece di no con la testa. “Allora chi è stato?” insistetti. “Un monaco”.
Dopo quelle parole lasciai Lucio per correre alla casa del Maresciallo, accanto alla caserma, che mi accolse in vestaglia.
Passammo tutta la notte a collegare punti sul mio quaderno e la mattina dopo, troppo indaffarati per riposare, facemmo un po’ di ricerche in archivio. Mia moglie ci sorprese in caserma sommersi da documenti e mi sgridò davanti al Cioni per averla fatta preoccupare tutta la notte. Poi il Maresciallo l’abbracciò all’improvviso dicendo “Meno male che c’è il su’ marito!” allora lei si irrigidì, sorrise imbarazzata e disse che mi aspettava a casa quella sera. Quella fu l’ultima volta che le ho dato preoccupazioni, lo giuro, anche perché il caso era praticamente risolto.
Come spinti da una dimenticata voglia di vivere fanciullesca, andammo all’anagrafe in paese alla ricerca di un cognome in particolare, poi cercammo nel catasto gli atti della compravendita dei terreni sulle Serre. Infine sfrecciammo con la volante per le strade di Pisa, che io non avevo mai visitato, dove l’Intendenza di Finanza confermò che Alberto Secondo Cini aveva ancora un grosso debito per la costruzione della ditta sulle serre. Tirai un sospiro di sollievo. Il movente ormai era stato individuato: la morte misteriosa del cugino avrebbe assicurato al barone una bella eredità, essendo Don Fausto privo di discendenti e di altri parenti stretti. Ma visto che il barone, i maiali, li fa sgozzare a quell’altri, sapevamo che non era stato lui ad aver commesso l’omicidio. Anzi, forse se ci fosse stato lui avrebbe ucciso il prete giusto. Perché aveva mandato un suo scagnozzo, uno di quei ruffiani di cui aveva parlato Claudia, che la sera del 15 settembre 1979 era stato buttato fuori dal bar di Italo perché aveva bevuto troppo e non poteva pagare. Si chiamava Giammaria Lo Monaco, ed erano sue le mani che avevano trascinato il prete su per il campanile e l’avevano lanciato nel vuoto. Lucio arrivava da Via Roma quella notte e si dirigeva in giù verso Via Carraia: proprio grazie alla sua instancabile camminata il vecchio aveva visto Lo Monaco entrare in chiesa, lo aveva sentito urlare, poi aveva visto il corpo precipitare dal cielo, e di nuovo Lo Monaco che fuggiva dal portone laterale e correva verso Via Borgherucci. Ci mettemmo tanto tempo per tirare fuori una testimonianza da quel povero storpio che ogni quarto d’ora si dimenticava chi fossimo. Appena ottenuto il mandato di arresto il Maresciallo interrogò lo scagnozzo del Barone (al cui cappotto mancavano due bottoni) e lo vidi sorridere, uscendo dall’ufficio con la confessione scritta in mano.
Sono passati solo cinque anni dall’accaduto. Eppure, a vedere tutti i miei compaesani riuniti in chiesa non riesco a non pensare a quando questi volti non significavano ancora nulla per me. La ditta del Cini è stata chiusa, e sebbene l’indagine dell’omicidio sia terminata velocemente, quella per i debiti e per i maltrattamenti dei dipendenti lo terranno occupato ancora per un po’. Il paese è tornato quello di prima, con un nuovo prete per la sua perpetua, e con tante notizie che animano le discussioni al bar. Quello che manca però è la risata stridula di quel vecchio storpio che adesso porto sulla spalla, assieme al Maresciallo e ad altri due carabinieri. Berta mi cammina accanto, in mezzo a centinaia di pecciolesi, e procediamo in silenzio verso il cimitero.
Lucio il folle, quello che a modo suo ha rivelato la parte oscura della collina di Peccioli, è morto a novant’anni in una domenica di fine estate. Dopo aver sopportato due guerre mondiali, un’alluvione e un omicidio, quel corpo fragile e silenzioso si è spento su una panchina sotto le logge, quando finalmente aveva deciso di riposarsi.
_______________________________
In caduta libera di Vittoria Giaganini è stato realizzato alla fine del Corso di scrittura dal titolo Storie a tinte gialle, promosso dalla Fondazione Peccioli per l’Arte e condotto dal giornalista Andrea Marchetti alla Biblioteca Fonte Mazzola.
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI