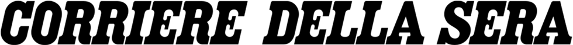La prostata
di Libero Venturi - Domenica 23 Febbraio 2020 ore 07:30

Mi sono operato alla prostata. Alla fine mi sono deciso. Ho preso il coraggio a quattro mani. Che non ho mai capito come si fa, avendone solo due e, per quel poco coraggio che ho, due ne bastavano, anzi avanzavano. Ne sarebbe bastata una. Non mi addormentano, come chiedevo, dice che è peggio. Mi fanno la spinale. Ho chiesto: sentirò male? Perché io non solo ho paura di soffrire, ho paura anche se penso che forse soffrirò. Il male non soltanto si sente, si immagina pure. Glielo potrei tagliare e non sentirebbe nulla, mi ha risposto il dottore. Sono parole che rincuorano.
Mi operano infatti passando dal pene. TUR-P, elettroresezione prostatica transuretrale. Sapere che da lì passa qualche altra cosa rispetto al normale è un pensiero che fa rabbrividire. Se dovevano partorire i maschi, la razza umana si sarebbe già estinta da un pezzo. Nel frattempo, per non farmi mancare niente, è insorta anche un’ernia inguinale, probabile lascito di tanti traslochi. Chiedo: già che ci siamo e mi fate il punturone, perché non mi operate anche quella? Una specie di tre per due, insomma. Non mi hanno degnato. Ho capito che non era cosa.
Supero la preospedalizzazione a pieni voti. La data fissata per l’intervento è i primi di febbraio. Gli ultimi di gennaio l’ospedale telefona: si è liberato un posto per malattia del candidato, vuole anticipare? Mi consulto con la mia compagna, rispondo sì. Prima ci togliamo il pensiero e un po’ di prostata, prima smettiamo con quelle deprimenti pillole giornaliere e recuperiamo pure una minzione decente. Il resto si vedrà. Tutto decresce con l’età, solo la prostata ingrossa, vigliacca! Gli uomini, nella specie umana, sono il genere con caratteristiche recessive.
Arriva il giorno dell’operazione: presentarsi non mangiati e nemmeno bevuti alle sette, all’Ospedale, in chirurgia A. Con Anna siamo arrivati puntuali. Chiamano tutti soltanto per nome: è la privacy. Ma il mio beneamato nome non viene pronunciato. Eccesso di privacy? Vado a chiedere. Sono un sostituto, ci sono problemi? Mi chiamerete? Nessun problema, tutti quelli in elenco verranno chiamati, torni in sala d’aspetto, per favore, risponde la solerte infermiera. Sono un paziente, paziente, e torno in sala d’aspetto.
Sennonché la domanda era sbagliata. Quella giusta sarebbe stata: scusi, il mio nome è nella lista? La pone, dopo un’ora di attesa, la compagna, più capace ed incisiva. E la risposta è: sì c’è, ma in chirurgia B. Però sul foglio avete scritto A. Non l’abbiamo scritto noi, si giustificano. Vabbè, niente di che. In effetti sono quarto o quinto in graduatoria e mi toccherà all’ora di pranzo. Pranzo si fa per dire: digiuno per me. Mi assegnano un letto e mi metto in pigiama. Attesa snervante. Finalmente arriva la barella che mi prende in consegna: ultima pipì, ultimo bacio, mi spoglio, indosso un camice azzurro aperto sul retro e via, verso il mio destino. Penso nell’ordine: che la forza sia con te! E: ma chi me l’ha fatto fare?
C’è un’attesa tecnica anche davanti alla sala operatoria per gli ultimi rilievi e la preparazione all’intervento. Tutto è preciso, ma anche informale. Sembra di essere in piazza del mercato. Un po’ ti rilassi, un po’ no. Tra un’operazione e l’altra, il personale fa crocicchio. Si scambiano impressioni e battute: il corona virus con tutto quello che passa qui, a noi ci fa una sega, è quella che più mi è rimasta impressa, oltre ad una discussione sui turni di lavoro. Mi aspettavo silenzio ovattato e musichette rilassanti. Di interventi chirurgici subiti molti anni fa ho questo ricordo. Ma forse mi sbaglio con “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, il film, che erano matti, o presunti tali.
Dico: ok faccio l’epidurale, ma vorrei essere sedato. Non vedo, non sento e non parlo. Un po’ come le scimmiette. Non certo un cuor di leone. Dormirà, dormirà, mi risponde l’anestesista di sfuggita. In effetti mi siedono sul tavolo operatorio, appoggio i piedi al panchetto. Mi fanno una prima puntura. Le gira la testa? No, faccio, spavaldo. E poi non sento più niente. D’improvviso mi sveglio durante l’intervento e chiedo quanto tempo c’è ancora. Quello che ci vuole, risponde il dottore. Forse giustamente un tantino seccato. D’altra parte proprio in gita di piacere non siamo. Ma nemmeno lui. Mi sedano ancora. Meglio. Il dottore alla fine dirà tutto bene, lei però era un po’ agitato. Chissà cos’ho combinato? Troppo in apprensione, poi mi ha detto. Apprensivo è un dono di natura!
Il ricovero dura i quattro giorni previsti. Un fastidioso catetere. Letto spezza schiena, guanciali tortura per la cervicale. Smanio. A casa vado presto. Il film non è lo storico “Sangue e arena”, ma un inedito “Sangue e urina”. Fossi stato una donna ancora in età fertile, una volta al mese mi sarei svenuta. Ho provato perfino la vergogna precoce di pannoloni contenitivi. Però “for Men”, cazzo! Sembravo la controfigura di Panariello al Ki-ti Ka-ka di Orbetello: si vede il marsupio? Il marsupio sì, sì, sì, il marsupio sì, sì, sì! Poi è passato. Cessato il sanguinamento, cioè finito di donare sangue al cesso, me lo sono tolto. Ho dovuto ingurgitare tanta di quella acqua che è proprio vero: è un bene prezioso, mal distribuito nel mondo, a chi troppo e a chi niente. Sono esperienze che ti provano. Il mio alter ego pessimista e malinconico introita e registra tutto il senso di declino che ne deriva, ma questi sono solo fatti miei.
Del resto è vera una cosa: dottori e infermieri spesso ci appaiano cinici, ormai abituati al loro lavoro che riguarda la nostra sofferenza e il modo di rimetterci, ove possibile, a posto, in salute. E a volte lo sono. Però anche noi, ormai, non concepiamo più nemmeno il senso del dolore, ne abbiamo paura. E se è giusto non soffrire gratuitamente, tuttavia non possiamo arrivare ad escludere che una sofferenza si debba affrontare per migliorare la nostra condizione e guarire, se possiamo farlo e la vita ce lo consente ancora. Non è bello, né giusto da dire, ma le donne soffrono per metterci al mondo. Si può evitare. Sono certo che se toccasse agli uomini partorire, sempre ammesso che volessero farlo, lo eviterebbero sempre. Perché meno coraggiosi e più insofferenti. Insomma sono parecchio fi’oso, direbbe la mi’ nonna.
Alla fine, a parte tutte le osservazioni che si possono e si devono fare per migliorarci, devo dire, che la sanità pubblica è una figata. Ho avuto un intervento con tecnologia all’avanguardia e questo mi è stato assicurato dallo Stato Sociale. Non ho dovuto pagare o esibire polizze assicurative. Che si sia poveri o ricchi, questo ci viene in egual misura, universalmente, assicurato. Personalmente sono anche convinto della possibilità e dell’opportunità dell’integrazione tra sanità pubblica e privata, nella cornice dell’intervento pubblico, tuttavia spesso ci dimentichiamo ciò che lo Stato ci garantisce. E invece, oltre ogni rilievo critico, questo è il concetto da difendere e, se possibile, estendere. Senza mai indulgere nel giudizio di “malasanità”, che pure episodicamente si rileva, fino a decretare l’inutilità o la fine della sanità pubblica. Infine un ringraziamento, bravissimi tutti quanti: dottori, infermieri, personale sanitario. A loro la sanità pubblica deve molto, se non tutto. Anche sul piano umano. E pure la mia prostata privata. Grazie anche ai miei cari, che mi hanno visitato, supportato. E sopportato, la cosa più difficile.
Quindici giorni di convalescenza. Magari una visita di controllo, per sicurezza, avrei gradito fosse stata prevista. La faremo, mi hanno detto, quando avremo completato le analisi. E speriamo bene. Il recupero verrà. Ci voglio e ci devo credere. La vita continua. Se riesco a farmi anche l’ernia riprenderò a fare jogging. E chissà se ai futuri Giochi Paralimpici ammetteranno le categorie “ernia asportati” e “operati di prostata”. Buona domenica e buona fortuna.
Pontedera, Febbraio 2020
Libero Venturi